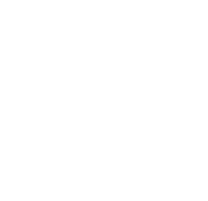La Pajara salentina, conosciuta anche come Pagghiara, è una tipica costruzione rurale del Basso Salento, realizzata con la tradizionale tecnica del muretto a secco, che prevede l’impiego esclusivo di pietre incastrate tra loro senza l’uso di malta o leganti. Queste strutture, diffuse prevalentemente nella campagna salentina tra uliveti, vigneti e muretti divisori, rappresentano un autentico esempio di architettura spontanea, perfettamente integrata nel paesaggio circostante e pensata per rispondere a esigenze pratiche legate alla vita agricola.
Originariamente nate come rifugi isolati per pastori e contadini, utilizzati per ripararsi dal sole e dalle intemperie o per custodire attrezzi, bestiame e prodotti della terra, le pajare potevano anche essere affiancate in gruppi di due o tre unità, dando origine a piccoli complessi abitativi stagionali. La loro struttura è generalmente circolare o ellittica, con una pianta compatta e muri a secco molto spessi, capaci di garantire un isolamento termico naturale sia in estate che in inverno. La copertura a falsa cupola, detta anche “tholos”, è realizzata sovrapponendo anelli concentrici di pietre fino a chiudere la sommità, secondo un principio statico simile a quello delle antiche costruzioni megalitiche.
La datazione di queste costruzioni è tuttora oggetto di dibattito. Alcuni studiosi ipotizzano che la loro origine possa risalire a circa il 1000 a.C., mentre altri si spingono ancora più indietro nel tempo, fino all’età del Bronzo (2000 a.C.), ipotizzando un legame con le culture protostoriche del Mediterraneo. La natura dei materiali e la vulnerabilità strutturale delle pajare, unite all’assenza di tecniche conservative nel tempo, fanno pensare che le strutture oggi visibili nel territorio siano in gran parte ricostruzioni o rifacimenti di epoca più recente, probabilmente risalenti a qualche secolo fa, tra il XVII e il XIX secolo. Nonostante ciò, esse conservano un valore etno-antropologico straordinario, testimonianza dell’ingegno contadino e della simbiosi millenaria tra uomo e territorio nel cuore del Salento.
Un rifugio per i contadini
Le Pajare, per i contadini salentini, rappresentavano un vero e proprio rifugio che poteva servire come alloggio estivo ma anche da riparo in caso di improvvisi e violenti temporali. In queste strutture era possibile trovare riposo dopo un’intensa giornata di lavoro oppure venivano utilizzate per vigilare sul bestiame o sulle coltivazioni. I contadini spesso, nel corso dell’erezione della pajara, inserivano nell’intercapedine del muro una figurina votiva, la cui funzione era quella di propiziare i buoni raccolti e assicurare la protezione dagli spiriti malefici.
Oltre alla loro funzione pratica, le pajare avevano anche un forte valore simbolico e identitario per le comunità rurali. La loro costruzione richiedeva abilità tramandate oralmente di generazione in generazione, e il completamento di una pajara veniva spesso celebrato con piccoli riti o gesti scaramantici. L’interno, seppur spoglio, poteva essere arricchito da nicchie scavate nella muratura, utilizzate per riporre utensili, lanterne o piccoli oggetti personali. In alcuni casi, attorno alla pajara si sviluppava un microcosmo agricolo fatto di pozzi, cisterne, muretti a secco e orti recintati, testimoniando la capacità del contadino di plasmare il paesaggio in modo funzionale e rispettoso della natura.
Trulli non trulli
Apparentemente, le pajare potrebbero sembrare dei trulli, ma non lo sono. Le pajare, infatti, sono costruite in aperta campagna, spesso isolate. Si caratterizzano per un ambiente piccolo, spartano, senza finestre, fronzoli e orpelli. Si tratta, come anticipato, di costruzioni rurali destinate a contadini e allevatori quindi, essenzialmente povere. I trulli, invece, sono corredati da finestre, vantano ambienti più spaziosi, comodi e confortevoli.
Anche dal punto di vista storico e urbanistico, le due tipologie edilizie rispondono a logiche differenti: mentre i trulli si sviluppano soprattutto nel territorio della Valle d’Itria, spesso in contesti urbani o aggregati rurali pianificati (come ad Alberobello), le pajare sono frutto di un’edilizia spontanea, legata alla frammentazione del territorio agricolo salentino. Inoltre, le tecniche costruttive pur condividendo il principio della falsa cupola autoportante, si distinguono per materiali e approccio: le pietre usate nelle pajare sono generalmente meno lavorate e posate a secco con maggiore semplicità. Le pajare, in definitiva, incarnano un modello di architettura povera, ma profondamente radicata nella cultura materiale del Sud Salento.
Tecnica di costruzione
Benchè possano apparire come costruzioni preistoriche, le strutture delle pajare hanno la capacità di mantenere l’ambiente fresco e asciutto anche durante le ore più calde o in presenza di un clima torrido. Questa caratteristica è da attribuirsi, principalmente, al materiale e alle tecniche utilizzate per la loro costruzione.
Le pietre che venivano usate per l’erezione di tali strutture sono di diverse dimensioni, sovrapposte ed incastrate tra loro con la tecnica del muretto a secco. La materia prima utilizzata era il pietrame calcare informe e, raramente, dei conci squadrati di tufo. Per i muri perimetrali interni ed esterni, si usavano gli spezzoni più grandi mentre, per le intercapedini, quelli più piccoli.
Il muro esterno si erigeva leggermente aggettante verso l’interno mentre quello interno sorgeva verticale per un metro e mezzo dopodiché si procedeva con la falsa cupola o sistema di copertura tholòs. La falsa cupola, retta solo grazie alla forza di gravità e ai contrasti laterali fra le pietre, veniva poi chiusa da una grande lastra chiamata “la chiave di volta”. Il piccolo terrazzo della pajara era impermeabilizzato per mezzo di un impasto fatto di terra fine, piccoli cocci di terra cotta e calce. Un altro importante elemento strutturale sono le scale laterali che si sviluppano a spirale da uno o entrambi i lati della struttura e la loro realizzazione era dovita alla possibilità di effettuare eventuali lavori di manutenzione alla pajara o per strasportare il materiale necessario al suo completamento.
Da architettura povera ad ambienti di lusso
Le Pajare nascono quindi come costruzioni rurali, espressione di un’architettura povera, essenziale e funzionale, legata alle esigenze del lavoro nei campi e alla sopravvivenza quotidiana. Nel corso degli anni, tuttavia, queste strutture hanno conosciuto una profonda trasformazione d’uso e di significato: da semplici rifugi di pietra sono diventate ambienti ricercati, valorizzati per il loro fascino arcaico, il legame con il territorio e la capacità di evocare un tempo autentico e silenzioso. Le pajare oggi sono spesso recuperate e integrate in progetti di ristrutturazione di pregio, diventando elementi centrali di residenze di lusso, relais di charme o dimore per vacanze esclusive.
La loro presenza, spesso armonicamente accostata a volumi contemporanei o ampliamenti minimalisti, contribuisce a conferire unicità architettonica e identità storica alle nuove costruzioni. Molte ville di nuova edificazione nel Basso Salento incorporano una o più pajare ristrutturate, valorizzandole con finiture di alta qualità, impianti moderni e soluzioni sostenibili. Internamente, gli spazi sono stati adattati per offrire comfort abitativi di alto livello, spesso con l’inserimento di zone relax, camere da letto, bagni rivestiti in pietra locale, cucine open space e affacci panoramici su giardini con ulivi secolari. Questo tipo di recupero attira un numero crescente di turisti e investitori, affascinati dall’idea di vivere o soggiornare in un luogo che rappresenta la sintesi perfetta tra tradizione, natura e innovazione. Le pajare, oggi, sono diventate veri e propri simboli del lusso identitario, capaci di raccontare il Salento in chiave contemporanea senza tradirne lo spirito originario.